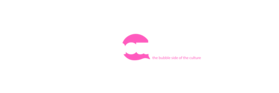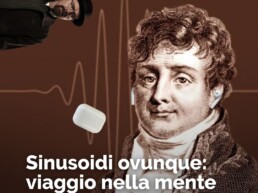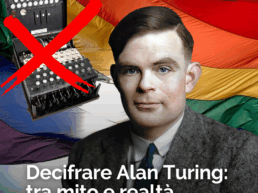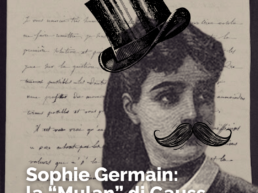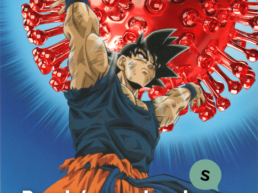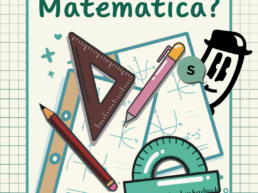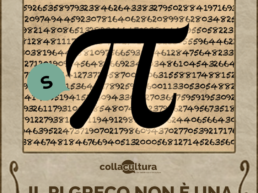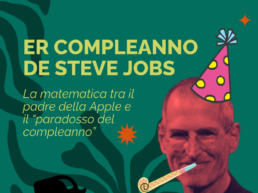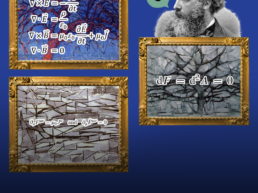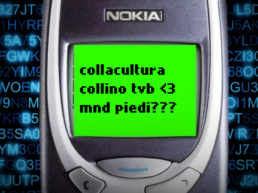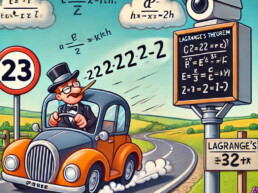Pompei vive. Ogni volta che pensiamo di conoscerla veramente, la città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. riesce a sorprenderci con nuove rivelazioni. È stata per secoli il palcoscenico più statico esistente: affreschi, luminosi, strade perfettamente intonse, corpi ibernati nella cenere come statue tragiche. Ma oggi, accanto all’archeologia e all’arte, comunichiamo con la città sepolta anche attraverso un nuovo linguaggio: il DNA.
Oggi possiamo infatti abbandonare, anche solo per un momento, la lettura di quel racconto scenografico e maestoso che ha caratterizzato ed influenzato il nostro rapporto con la città di Pompei, dedicandoci a una narrazione più intima.
Dai primi tentativi alle tecnologie di oggi
L’idea di recuperare DNA dai resti pompeiani sembrava, fino a pochi decenni fa, un sogno quasi impossibile. L’idea nacque negli anni ’90, quando un gruppo di ricercatori tentò di estrarre del DNA direttamente dalle ossa e dai denti delle vittime, ma il risultato fu deludente: frammenti troppo corti, facilmente contaminati, e tecniche di indagine ancora troppo rudimentali.
Poi, nel giro di vent’anni, la tecnologia ha fatto un balzo in avanti. Con una nuova tecnologia, definita Next Generation Sequencing (o sequenziamento di nuova generazione), è possibile leggere miliardi di sequenze di DNA in poche ore.

A questo si aggiunge, inoltre, la “bioinformatica”, una disciplina che coniuga l’informatica alla biologia ed è in grado di confrontare i dati genetici con enormi banche genomiche globali per ricostruire parentela, provenienza geografica e persino la predisposizione a malattie.
A raccogliere la sfida per la prima volta fu il Parco Archeologico di Pompei, che grazie alla collaborazione di numerosi centri di ricerca, tra cui il Max Planck Institute, avviò nel 2015 il progetto POMPEII Molecular Portrait. Questa iniziativa da sempre possiede come primario obiettivo la possibilità di costruire una mappa genetica dettagliata della popolazione pompeiana attraverso l’analisi del DNA estratto dai resti sepolti dall’eruzione del 79.
Le storie nascoste dietro i calchi
Chiunque abbia visitato Pompei ricordale sagome bianche in gesso ottenute nell’Ottocento grazie all’intuizione di Giuseppe Fiorelli, che ebbe l’idea di colare il gesso nelle cavità lasciate dai corpi nella cenere, dando così origine ai celebri calchi. Quei corpi contorti, con mani alzate e volti coperti, sono diventati un’icona universale della tragedia. Eppure, spesso, le interpretazioni nate attorno a quelle figure erano più immaginazione che realtà.

Nella Casa del Braccialetto d’Oro, quattro scheletri ritrovati sotto una scala erano stati a lungo interpretati come una famiglia in fuga: madre, padre e due figli, interpretazione rafforzata dalla presenza di un prezioso monile d’oro. Tuttavia, l’analisi del DNA antico ha fornito una storia completamente diversa: il confronto dei profili genetici dei quattro individui ha permesso di determinare varie informazioni, rivelando che si tratta di uomini adulti non imparentati tra loro.
La genetica ha inoltre ribaltato completamente anche la nostra visione su un’altra immagine simbolica forse anche più conosciuta: quella dei due corpi stretti in un abbraccio, letti come madre e figlio o fratelli uniti nella morte. Beh, anche in quel caso si tratta di due uomini adulti non imparentati tra loro.

Una città di migrazioni e incontri
Grazie all’analisi del DNA antico, l’immagine di Pompei si sta progressivamente affinando: ciò che emerge non è più la fotografia immobile di una città cristallizzata nel tempo, ma il ritratto di una comunità dinamica, sorprendentemente simile a una città moderna, attraversata da individui provenienti da diverse regioni del Mediterraneo.
Ad esempio, la prima volta in cui siamo stati in grado di ricostruire un genoma dalla città di Pompei è stato nel 2022, anno in cui gli scienziati hanno sfruttato lo scheletro rinvenuto nella Casa del Fabbro per comporne il DNA.

Questo ci ha permesso di ottenere informazioni di estrema rilevanza; per esempio, il profilo genetico rivela una forte affinità con le popolazioni dell’Italia centrale di età romana, segno che la città era profondamente radicata nella penisola. Ma c’erano anche tracce di origini più lontane, dall’Europa orientale e dal Mediterraneo, a conferma di un tessuto urbano multietnico.
E non finisce qui. Le ossa mostrano segni compatibili con la tubercolosi ossea, e i ricercatori hanno persino isolato frammenti di DNA di Mycobacterium tuberculosis, il bacillo responsabile di una delle malattie infettive più diffuse e letali della storia, la tubercolosi. Per la prima volta, oggi non solo sappiamo chi fosse quell’uomo, ma anche di quale malattia soffrisse, e quali patogeni circolassero nella Pompei del I secolo.
Gli aplogruppi genetici
In questo contesto, un ruolo centrale è giocato dagli aplogruppi genetici, ovvero insiemi di mutazioni ereditate lungo una linea materna (DNA mitocondriale) o paterna (cromosoma Y). Questi marcatori funzionano come “firme genetiche” che consentono di ricostruire rotte migratorie e rapporti di parentela su scala millenaria.
L’analisi degli aplogruppi nei pompeiani ha rivelato una notevole eterogeneità: accanto a linee genetiche tipiche dell’Italia centrale romana, sono emersi aplogruppi riconducibili al Mediterraneo orientale e all’Europa balcanica. Ciò testimonia la presenza a Pompei di individui non autoctoni, probabilmente mercanti, artigiani o schiavi, inseriti nel tessuto sociale ed economico della città.

Scienza contro mito
Per secoli siamo stati abituati a una lettura della città da una prospettiva estremamente romantica e narrativa: la madre che stringe il bambino, il padre che protegge la famiglia, l’abbraccio tragico dei corpi. Tali interpretazioni, nonostante fossero molto suggestive, si basavano prevalentemente su osservazioni morfologiche e contesti archeologici superficiali, e spesso riflettevano categorie culturali più che realtà biologiche.
Questa nuova prospettiva genetica e bioarcheologica sostituisce narrazioni simboliche fornendoci dati concreti: non possiamo più permetterci di considerare gli individui di Pompei come rappresentazioni astratte modellate da affetti o drammi familiari, ma parliamo di umani reali, caratterizzati dalla loro diversità biologica, genetica e sociale.
Riconoscere questa realtà, anche quando contrasta con immagini consolidate a cui tutti noi ci siamo abituati, costituisce una forma di rispetto sia dal punto di vista etico che scientifico: restituisce dignità alle vittime e permette di comprendere Pompei come comunità vivente, complessa e dinamica, piuttosto che come “tableau” congelato di tragedie simboliche.

Qual è il futuro di Pompei?
Il prossimo obiettivo della ricerca su Pompei consiste nella costruzione, come già detto, di una mappa genetica completa della popolazione della città, mediante il sequenziamento del DNA di decine, se non centinaia, di individui sepolti sotto la cenere. Questo approccio, basato su tecniche di estrazione di DNA antico, NGS e analisi bioinformatica avanzata, permetterebbe di ricostruire l’identità biologica complessiva della comunità pompeiana, delineando non solo le origini geografiche e i flussi migratori, ma anche la distribuzione di malattie, eventuali differenze genetiche legate a stratificazioni sociali e persino informazioni sulle abitudini alimentari attraverso il DNA conservato in denti e tessuti mineralizzati.
Pompei, così studiata, smette di essere un semplice reperto archeologico congelato nel tempo e si trasforma in un laboratorio di biologia molecolare e paleogenomica, in cui gli individui, fino a ieri rappresentati solo da calchi in gesso, riacquistano una concreta identità biologica.
Bibliografia
- Scorrano, G., Viva, S., Pinotti, T., Fabbri, P. F., Rickards, O., & Macciardi, F. (2022). Bioarchaeological and palaeogenomic portrait of two Pompeians that died during the eruption of Vesuvius in 79 AD. Scientific Reports, 12, 6468. https://doi.org/10.1038/s41598-022-10899-1
- Mittnik, A., et al. (2024). Ancient DNA challenges prevailing interpretations of the Pompeii casts. Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.10.012
- Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (2024). DNA evidence rewrites story of people buried in Pompeii eruption. Comunicato stampa. Disponibile su: https://www.mpg.de/23699890/
- Biotechniques. (2024). Rewriting the history of Pompeii with ancient DNA analysis. Disponibile su: https://www.biotechniques.com/pcr-sequencing/rewriting-the-history-of-pompeii-with-ancient-dna-analysis/
- Parco Archeologico di Pompei. (2015–). Pompeii Molecular Portrait Project. Comunicati ufficiali e materiali divulgativi.
2025-08-29
Sinusoidi ovunque: viaggio nella mente di Fourier
Cosa lega il principio di indeterminazione di Heisenberg, le AirPods e un…
2025-08-08
Le mail spam a 3km da te
Addentriamoci in uno degli enigmi più fastidiosi dell’era digitale: le mail…
2025-07-21
Gatti e multiversi: interpretare la fisica
Tutta la fisica è interpretabile? Oggi parliamo di fisica classica,…
2025-07-04
Tazze, ciambelle e topologia
Dalle tazze che diventano ciambelle alle cariche elettriche conservate, la…
2025-06-23
Decifrare Alan Turing: tra mito e realtà
In occasione del compleanno di Alan Turing, cogliamo l’opportunità per fare…
2025-06-18
Perché allattano solo le femmine?
Ho un dubbio che mi assilla: perché solo le femmine allattano? Facciamo un…
2025-05-13
BAMBINI DA LABORATORIO
He Jankui, un biofisico cinese, ha sperimentato la modifica genetica sugli…
2025-04-30
Sophie Germain: la “Mulan” di Gauss
Il 30 aprile festeggiamo il compleanno di Gauss: quale occasione migliore per…
2025-04-16
Perché non riusciamo a sconfiggere l’HIV?
I virus non sono tutti uguali, ed alcuni di loro possono essere molto…
2025-04-06
Ho la testa tra le quadriche
Uno splendido viaggio matematico nel mondo delle quadriche in pieno spirito…
2025-04-02
Evo: giocare a scacchi con la genetica
L’IA evolve rapidamente: Evo 2 analizza il DNA, prevedendo mutazioni genetiche,…
2025-03-27
Tu sai studiare la Matematica?
Molti studenti imparano formule matematiche come fossero filastrocche. Testiamo…
2025-03-14
IL PI GRECO (NON) È UNA COSTANTE
II pi greco non vale sempre 3,14... Esistessero altre geometrie che influenzano…
2025-02-23
Er compleanno de Steve Jobs
In una classe di 23 persone la probabilità che due festeggino il compleanno lo…
2025-01-20
Chi taglia i capelli al barbiere?
Le domande esistenziali sono tante, ma la più importante è: "Chi taglia i…
2024-12-17
Equazioni di Maxwell: arte contemporanea
Cosa accomuna le equazioni di Maxwell e l'arte astratta? Entrambe sempre più…
2024-12-09
Un robot per amico: l’AI e le sue creature domestiche
L'AI riempie le mura domestiche nelle vesti di "coinquilina". Che tipo di…
2024-12-03
SMS: bei tempi… o forse no
Non facciamoci ingannare dalla nostalgia: gli SMS sono uno strumento…
2024-11-26
Safety Tutor: un motivo (in più) per odiare la matematica
Dietro le multe per eccesso di velocità si nasconde il teorema di Lagrange. Un…
2024-11-21
Smentire Omero con la fisica
Il fisico irlandese Samuel Haughton ha studiato il modo più efficace per…
2024-11-18
Gratta e Vinci: come diventare poveri
I Gratta e Vinci sono croce e delizia di molti italiani. Ma davvero ti…